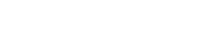In queste righe parlerò della mia nonna materna “nonna Dina”. Non so quanto le azioni di questa persona siano state importanti.
“Mia nonna era nata a Spicchio; aveva 4 sorelle ed un fratello; era abituata alla fatica perché era rimasta orfana di padre da piccola. Sua madre le aveva insegnato l’onestà e la dignità. Si sposò a 19 anni e si trasferì a Casenuove. A soli 20 anni si trovò con una bambina piccola e il marito in prigione arrestato per i “fatti del 21” come noto antifascista. Fu processato e scagionato dopo un anno perché in quel triste giorno del ’21, era nata la sua bambina, e lui era con la moglie e la balia. Purtroppo la bambina morì mentre il babbo era in carcere. Mia nonna superò questo momento: lavorava la terra e impagliava i fiaschi (partecipò anche a varie proteste delle “fiascaie”). Ebbe un’altra bambina e, dopo 9 anni, un maschietto. In casa sua c’era sempre la merenda per qualche bambino di famiglie disagiate. Dina aveva abbracciato le idee politiche del marito e faceva propaganda insieme a Rina Chiarini. La situazione divenne pericolosa: avevano ospitato in casa dei clandestini dalla Francia (uno era Negarville). Durante una perquisizione furono trovati dei volantini e mio nonno fu arrestato. Era il 1937 ed è uscito dopo l’otto settembre del ’43. È morto pochi mesi dopo senza vedere la fine della guerra. Nel 1938 Dina si era trasferita da Casenuove a Santa Maria, dove viveva sua madre e una sorella, in modo da avere qualche sostegno. In tutti quegli anni ha mantenuto la famiglia ed è riuscita a far studiare sua figlia (mia madre) alle “Scuole Magistrali”. Mio nonno scriveva dal carcere preoccupato di non poterla aiutare. Mia madre, diventata maestra, ha potuto trasmettere ai suoi scolari l’importanza di riuscire a superare le difficoltà mantenendo l’onestà e la compassione (non ho mai sentito mia madre maledire chi aveva fatto tanto male ai suoi genitori).
Nel primo dopo-guerra, molte persone non avevano più una casa e Dina ha ospitato in casa sua alcune famiglie. Ricordo che si parlava di una famiglia di Genova: lei considerava i loro bambini come suoi figli e sono rimasti a lungo in contatto anche dopo quel difficile periodo. Negli anni ’60 fu costruito un grande palazzo vicino alla casa di Dina. Tra le persone che ci abitavano, una famiglia si trovò in difficoltà: il padre di tre bambini si era ammalato; la moglie doveva accudirlo. Quando ero lì (abitavo vicino, avevo circa 10 anni), capitavano spesso questi bambini e rimanevano a pranzo oppure tornavano nella loro casa con un “pentolino”, della frutta e della verdura coltivata da mia nonna. Ricordo Dina anche vestita a festa per andare al “corteo” del Primo Maggio: non ne ha perso neanche uno! Per lei difendere il lavoro e i lavoratori era una priorità della vita.
Quello che ricordo più volentieri era il suo lavoro di “fiascaia”: si radunavano a casa sua almeno tre o quattro donne; anche io davo una mano per le cose più semplici. Mia nonna aveva le mani piene di piccoli tagli nel maneggiare il “salicchio” (un’erba molto tagliente); lei avvolgeva le ferite con il “nastro isolante” (non c’erano i “cerottini” di oggi). Vedo anche ora quelle mani robuste (quasi maschili), ma ricordo che in quella stanza si cantava di continuo: storie di guerra, storie d’amore, stornelli. Anche così, con quei canti corali, mi ha insegnato dei valori come il coraggio di affrontare la vita. Valori che spero di aver trasmesso ai miei figli ed ora anche ai miei nipoti.”
Motivi e motivazioni per le quali si ritiene di presentare questa candidatura
MANUELA VEZZOSI: Non ho conosciuto la bisnonna Dina, ma fin da piccola ho sentito persone parlare e raccontarmi di lei, non solo parenti, anche semplicemente vicini di casa che volentieri ricordavano questa forte e altruista donna di Santa Maria. Ho partecipato da piccola a commemorazioni antifaciste in ricordo del mio bisnonno Faustino Mugnaini e dei suoi compagni, poco si racconta delle donne che nel loro silenzio, ansia e sofferenza sostenevano come potevano questi uomini, pazientemente attendevano il ritorno dalla prigione, dalla guerra o dalle lotte partigiane curando i propri figli e anche i figli di chi non sarebbe più tornato.
Ormai sono passati più di 40 anni dalla morte di nonna Dina e molte persone che l’hanno conosciuta, non ci sono più, solo mia mamma parla ancora di lei, della sua “minestra per chi ha fame”, delle sue canzoni d’amore, di guerra e di pace.
FULVIA ANCILLOTTI: Nota per la commissione – Mi sembra importante che resti vivo il ricordo di chi ha dato molto di sé per gli altri e quindi ho molto apprezzato questa iniziativa; sicuramente chi ha avuto l’idea del bando avrà già pensato a quanto voglio comunque rimarcare: ho inviato la storia della mia nonna materna (e della mia famiglia) non pensando che sia scelta come più rappresentativa, ma nella speranza che le storie pervenute siano raccolte e diventino un patrimonio comune da poter leggere e tramandare.
Ho scelto di parlare di mia “nonna Dina”, ma non so quanto le azioni di questa persona abbiano avuto una ricaduta sulla comunità. Ormai sono passati più di 40 anni dalla sua morte e molte persone che l’hanno conosciuta, non ci sono più, ma ricordo chi parlava di lei con mia madre (discorsi pieni di elogi) e ho tanti ricordi di quando ero bambina vicino a lei.
Altre informazioni utili
Gli episodi che ho raccontato sono riferiti da mia madre e da mia nonna, ma ci sono varie testimonianze riportate in un libro scritto dalla giornalista Aterini; si intitola “Casenuove e la sua gente”. Nel libro ci sono anche le lettere di mio bisnonno (Mugnaini) scritte dalla prigione.
Manuela Vezzosi e Fulvia Ancillotti